Dobbiamo impegnarci per trasformare in valore il “limite” ambientale
di Aldo Bonomi
La sostenibilità non è solo una questione di politiche o di mercato: senza una green society, un sistema di corpi intermedi capace di tradurre la svolta sostenibile in senso comune, non ci sarà nemmeno una green economy. La circolarità tra economia e società ha nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, varato dal governo Draghi, un possibile motore di accompagnamento e un fattore propulsivo
Le nostre società ormai da tempo vivono nella transizione permanente dei pilastri che le sorreggono. Impresa, mercato, società, sono termini il cui contenuto sta cambiando in profondità, perché ci siamo accorti che la crescita non può più avvenire per consumo delle risorse, ma trasformando in valore, il limite ambientale.
 Recentemente la Fondazione Symbola ha pubblicato dieci selfie che delineano l’immagine di un Paese che sta cercando di incorporare il senso del limite nel ciclo economico facendo leva su alcuni dei suoi pilastri costitutivi quali la vocazione esportatrice manifatturiera, il made in Italy, le filiere plurilocalizzate o, su alcuni deficit naturali come la scarsità di materie prime che ha fatto del Paese un precursore involontario dell’economia circolare. Il tutto rinforzato da un terziario del design che continua a mantenere, anche qui in continuità con la tradizione, un rapporto molto stretto con la manifattura più evoluta.
Recentemente la Fondazione Symbola ha pubblicato dieci selfie che delineano l’immagine di un Paese che sta cercando di incorporare il senso del limite nel ciclo economico facendo leva su alcuni dei suoi pilastri costitutivi quali la vocazione esportatrice manifatturiera, il made in Italy, le filiere plurilocalizzate o, su alcuni deficit naturali come la scarsità di materie prime che ha fatto del Paese un precursore involontario dell’economia circolare. Il tutto rinforzato da un terziario del design che continua a mantenere, anche qui in continuità con la tradizione, un rapporto molto stretto con la manifattura più evoluta.
C’è quindi un pezzo di Paese che pare ben instradato sul sentiero dell’economia sostenibile, un sentiero che di anno in anno si allarga coinvolgendo un numero sempre maggiore di imprese, che in questo nuovo ciclo di investimenti sta trovando il modo per riposizionarsi nelle catene di fornitura globali, che nella sostenibilità hanno individuato un nuovo ciclo espansivo.
Siamo un Paese che sta cercando di incorporare il senso del limite nel ciclo economico facendo leva su alcuni dei suoi pilastri storici: il patrimonio dei territori e delle “cento città”, il made in Italy, ma anche un’industria con punte di eccellenza e filiere plurilocalizzate che competono nel mondo. L’Italia è ben dotata di imprese eccellenti, utilities che sanno fare innovazione, un bacino di saperi terziari e un tessuto di organizzazioni comunitarie, dal volontariato alle grandi fondazioni, che può fare da infrastruttura sociale sulla quale reggere e far leva.
La capacità di fare tessuto di questa intelligenza collettiva territorializzata nei distretti e nelle piattaforme produttive che costellano il Paese da nord a sud poggia sull’ossatura del capitalismo territoriale andato strutturandosi intorno al nucleo costituito da alcune migliaia di medie imprese del made in Italy teste di ponte nelle supply chain globali di filiere produttive in evoluzione. Made in Italy che, partendo dal sottoscala degli anni Settanta e passando dai distretti degli anni Novanta, è diventato, a suo modo, pilastro del soft power italico nel mondo. Piccolo potere, si dirà, di fronte alla strapotenza del “platform capitalism”. Eppure, qui siamo, qui ci tocca saltare, sapendo tuttavia che pezzi importanti di made in Italy, come quelli legati ai beni di consumo che identificano l’italian way of life, molto possono dire in tema di sostenibilità, molto possono veicolare in termini di orientamento delle culture dei consumi e degli stili di vita sostenibili, intessendo la ragnatela del valore intorno ed insieme ad un consumatore diventato consumattore, cioè attore non secondario nella strutturazione delle filiere. Segno che si tratta di un insieme di industrie (le 3F del food, fashion, furniture) che pongono il nostro capitalismo di territorio al centro, e non ai margini, del salto d’epoca dell’Antropocene. In questo sforzo collettivo in divenire occorre tuttavia evitare di pensare che la sostenibilità sia solo questione di politiche o di mercato che per cerchi concentrici diffondono i loro benefici automaticamente al tessuto diffuso del Paese. Come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, senza green society e una società che si mette in mezzo tra economia e politica, non ci sarà nemmeno una green economy, quella conversione ecologica capace di andare oltre l’Antropocene.
Senza una società verde, un sistema di corpi intermedi capace di tradurre il linguaggio della svolta ambientale in senso comune progressivo, sarà difficile governare i contraccolpi degli orfani dell’Antropocene rispetto ad altri segmenti sociali che trarranno benefici dalla transizione. Ecco perché dall’economia circolare occorre passare alla circolarità tra economica e società, tendenza da non confondere con l’industrializzazione incipiente della vita quotidiana che in qualche modo la pandemia sta accelerando. Circolarità tra economia e società che ha nel Pnrr un possibile motore di accompagnamento, un fattore propulsivo inclusivo che, speriamo, faccia da catalizzatore di energie sociali ed economiche e non solo da riserva di propellente. Non è questione di “guadagnare tempo”, del resto.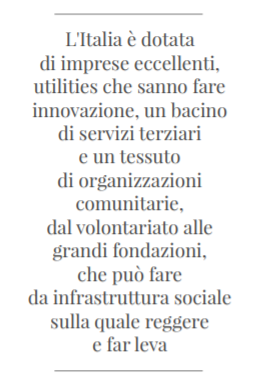
Abbiamo bisogno di una sfera sociale capace di includere in un’idea di prosperità green da mettere in mezzo tra politica in crisi, in attesa del concretizzarsi delle dichiarazioni green dell’Europa che verrà, e flussi dell’economia globalizzata. Tra i tanti nodi d’affrontare ne segnalo due. Il primo riguarda le forme del valore nell’epoca dell’Antropocene dispiegato. Eventi come le epidemie sembrano oggi consustanziali al modello di interconnessione globale dell’economia e della società. Di conseguenza l’impresa come luogo in cui comunità operosa e di cura si intrecciano, deve oggi uscire dalle mura della fabbrica per divenire organizzatore sociale. Non è più soltanto un fatto di responsabilità morale e personale dell’imprenditore, quanto di ripensare la morfologia di ragnatele del valore estese, per far rientrare nel calcolo economico la rigenerazione di beni collettivi come ambiente e salute (ma anche conoscenza e coesione), che costituiscono i legami a garanzia della relazione produttiva tra l’impresa e il territorio. Ciò significa, ad esempio, favorire la capacità di traino delle medie imprese rispetto al mare del capitalismo molecolare in filiera. Per quello che rimane uno dei terreni rigenerativi del nostro modo di competere nel mondo la sfida post pandemica si profila ardua se lasciata alle derive selettive del salto d’epoca. Con ciò non intendo difendere il “piccolo è bello” fuori tempo massimo, ma non c’è dubbio che molto può essere ancora fatto per passare da un’idea novecentesca di “lavoro in proprio” ad un’idea di impresa socializzata al “lavoro in rete”, siano essi reti digitali o di prossimità. Pensiamo, da questo punto di vista, a cosa significa il Salone del Mobile in cui si incrociano manifattura, industria culturale, turismo e rete diffusa del commercio, in cui una delle chiave del successo sta nel valore di connessione. È nel proporre soluzioni e innovazioni collettive che accompagnino le imprese verso questo modello di sostenibilità, in cui la questione ambientale diventa anche questione sociale e territoriale, che io vedo aprirsi lo spazio per una nuova poliarchia di corpi intermedi e rappresentanze che sappiano essere tessitrici e negoziatrici.
Utile sarebbe un patto tra comunità operosa degli interessi e comunità della cura e dell’impresa sociale, che rimetta al centro l’inclusività dello sviluppo sul perimetro delle grandi piattaforme produttive e territoriali che innervano la geografia economica e sociale del Paese. Un disegno che però può dispiegarsi non soltanto garantendo il mantenimento delle reti lunghe di mercato con le grandi catene del valore mondiali, ma affrontando finalmente il tema di un ripensamento profondo nel rapporto tra mondo dell’impresa (soprattutto diffusa) e statualità, consentendoci anche di uscire dalle secche di una discussione tutta incentrata sul “quanto stato” per mettere al centro invece la questione di “quale stato”. Il ritorno della statualità come potere di ultima istanza nell’emergenza, va oggi diluita nella capacità di pensare come intelligenza collettiva e rete di comunità concrete una statualità nuova, che rappresenti l’infrastruttura politica e amministrativa intelligente a servizio dei territori. Una statualità che accompagna ed innerva i territori con scuola, università, medicina di territorio, infrastrutture dolci delle piattaforme territoriali, dalle città sino ai piccoli comuni tenendo assieme smart city e smart land.
Questo spostamento di punto di vista potrebbe anche evitare il rischio che il Pnrr si configuri come un atto freddo, quando invece abbiamo bisogno di mobilitare le risorse “calde” della società per far sì che le scelte non si fermino alle punte alte, ma arrivino fino all’ultimo miglio dei soggetti più minuti, dei saperi sociali e della legittimazione che i corpi intermedi, nonostante le difficoltà, mantengono in questo Paese. Anche il tema della pervasività delle tecnologie, dell’economia dei dati e della redistribuzione del grande potere produttivo da esse sprigionato, rappresenta un campo di sperimentazione per ripensare il ruolo delle rappresentanze e dell’impresa dentro questa idea di cogestione diffusa. Nello sviluppo di questa capacità di accompagnare la società alle biforcazioni che la storia ci pone davanti, sono convinto risieda la grande opportunità, oltre che responsabilità, del momento che viviamo. Con Symbola abbiamo diffuso l’uso del termine “capitalismo dolce” a sottolineare una certa caratteristica del nostro modo di produrre che si riflette nei tanti selfie di speranza. Fiducia e speranza che più si diffondono più aumentano cittadinanza e mobilitazione sociale densa di passioni calde e di pratiche che, partendo dai territori del molteplice, danno voce al fare società e da questa al fare impresa. Un’impresa non più solo come progetto di vita, ma come progetto di vita sociale e dunque come attore di trasformazione nel non ancora del post-Antropocene.



